
Ho notato che lo spazio della stanza di meditazione è molto simile allo spazio del cuore. Per noi occidentali, il cuore è il luogo delle emozioni, dei sentimenti, delle passioni. Nel Buddhismo si dice invece che un Buddha, un essere risvegliato, abbia il cuore vuoto, che significa spazioso, ampio, un cielo in cui le emozioni, gli affetti, i pensieri, le opinioni (in sanscrito cuore e mente sono un termine solo: citta) passano, ma non permangono, sorgono e svaniscono. La non-identificazione con le inaffidabili emozioni, i discontinui pensieri, illumina la fondamentale vacuità dello sfondo, della coscienza, la vivezza di uno spazio che riceve con freschezza l’esperienza senza interpretarla, né evitarla, senza aggiungere, senza togliere, nudamente. Una stanza vuota insegna a essere contenitore vuoto, ma pronto, capace, accogliente. L’abilità di stare in una stanza vuota è quella di rendere altrettanto vuoto il proprio cuore, lasciar cadere le proprie opinioni, deduzioni, pregiudizi, lasciar scivolare quelle degli altri su di noi, lasciare che si riveli lo spazio vuoto di abitudini, un’altra possibilità.
In una stanza della meditazione, si impara a stare soli insieme. Si viene invitati a stare con noi stessi, a lasciare che il corpo e il cuore-mente rivelino da sé come stiamo, ma anche a percepire l’altro, a non ritirarsi, a non separarsi, a lasciar essere. E quello di cui ci si accorge allora, stando soli in compagnia, è che non esiste la mia consapevolezza, la mia pratica, ma un procedere insieme, un risvegliarsi insieme che è tutta una scoperta. E un modo d’incontrarsi senza perdersi né in sé né nell’altro.
Chi sono gli altri nella stanza di meditazione? Talvolta, si conosce appena il loro nome, si intravedono le facce e il corpo, di sera la stanza è quasi tutto il tempo illuminata solo dalle candele; è vero che c’è un tempo prima e dopo per incontrarsi informalmente, ma chiunque sente che non è quello il cuore dell’incontro. Nella stanza, non conta il nome, l’aspetto, il genere, la provenienza, la professione, lo stato civile e sociale, eppure c’è un incontro profondo. Spesso vedo nascere tra le persone un affetto originale e autentico, simile a quello fraterno. Quello che degli altri conosco di pili nell’esperienza della stanza è il loro silenzio. Il silenzio è un po’ come la luce, bisogna affinare i sensi per accorgersi di quante diverse sfumature di luce in una giornata incontriamo. E cosi per il silenzio. Ci sono infinite varietà di silenzio. Ogni silenzio dice qualcosa. Nello stesso tempo, il silenzio è solo silenzio. Non esiste il silenzio mio o tuo. Fare silenzio insieme è una profondissima comunione. Le diverse esperienze di vita, i diversi stati d’animo possono creare complicità o avversione, il silenzio consapevole unisce. Il silenzio sa. Nel silenzio s’impara.
Al silenzio si torna, come a un luogo conosciuto da tutti, da sempre. Una stanza in cui si fa silenzio è un luogo in cui s’impara ad accorgersi di quel che c’è già, a non trascurarlo, a non averne paura, a inoltrarsi, con fiducia, nel non-conosciuto. La stanza aiuta, è sempre li, uguale, una sera siamo disperati, un’ altra contenti, ci diciamo che va bene, ci diciamo che va male, la stanza sta. Cosi nel silenzio, senza nessuna presentazione, noi ci riveliamo tutti interi con i nostri veri nomi, generi, provenienze, lavori, amori, con i segni che tutto questo lascia in noi, con i segni che siamo.
Alla fine di una serata di meditazione, ognuno è invitato a dire com’è andata, come sta. Anche la parola sullo sfondo del silenzio e della stanza vuota ha una diversa consistenza: non c’è niente da dimostrare, nessun livello da raggiungere, semplicemente si dice com’è andata, difficoltà, dubbi, scoperte, gioie, passi, passaggi. E si ascolta. In una stanza senza appigli, si è meno distratti, è come un’eco che riproduce la voce dei nostri giudizi sulle parole degli altri, quella voce che spesso ci fa perdere la verità della loro esperienza.
Dunque, una stanza della meditazione è un rifugio che ci espone totalmente, come la consapevolezza, ci protegge, ci custodisce, ma ci rivela tutti interi a noi stessi. E una stanza che permette questo rivelarci, un luogo di cui potersi fidare, in cui potersi abbandonare, senza paura o insieme alla paura. Ricordo una persona, anni fa, che facendo un lavoro molto faticoso passava gran parte del tempo nella stanza a sonnecchiare anziché meditare. E quando, tutta vergognosa, ce lo confessò, io sentii di dirle che una stanza in cui poteva abbandonarsi al sonno doveva essere un luogo di cui si fidava. A poco a poco, senza fretta, il sonno lasciò il posto alla quiete.
Ho letto una storia di Chuang-Tzu, Maestro taoista del IV secolo a.C.
« C ‘era un uomo che aveva paura della propria ombra e orrore delle proprie impronte. Cosi le sfuggiva correndo. Ma quante più volte alzava il piede, tanto più numerose erano le impronte che lasciava; e più in fretta scappava, meno l’ombra l’abbandonava. Credendo di andare troppo piano, corse più svelto senza mai riposare, finché, all’estremo delle forze, non mori. Egli non capiva che per far scomparire l’ombra bisogna rimanere nell’oscurità, che per far cessare le impronte bisogna rimanere nella quiete».
Ecco, una stanza della meditazione non è un luogo esemplare, né dove essere esemplari, ma dove stare fermi nell’oscurità per conoscere la propria ombra e le proprie impronte. E per procedere oltre.
Da: Chandra Livia Candiani, “Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione“, Einaudi, 2018.
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione
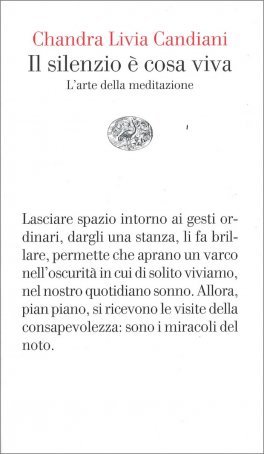
You need to login or register to bookmark/favorite this content.



