Yoga tradizionale: perché non esiste e non si pratica più

Lo yoga tradizionale ha ben poco a che fare con quello che pratichiamo oggi. Anche per questo non è facile orientarsi nell’ampia varietà di offerta tra i tanti tipi di yoga che oggi sono presenti sul mercato. Edoardo Beato in questa intervista ci aiuta a a capire quali sono gli elementi di distinzione tra yoga tradizionale e yoga moderno. E propone un modello, quello dei quattro elementi, per scoprire in noi stessi la più autentica realtà dell’esistenza.
Lo yoga che pratichiamo oggi è lo stesso che era diffuso in India migliaia di anni fa, che potremmo definire “yoga tradizionale”?
Lo yoga odierno è omonimo, ossia condivide la stessa parola, ma non è omologo allo yoga antico, quello che tu chiami yoga tradizionale La logica dello yoga moderno e di quello antico non sono equivalenti, anzi, siamo arrivati a un punto in cui potremmo parlare di divergenza. Questa differenza non riguarda soltanto il confronto con le prime definizioni di yoga — che risalgono intorno al VI-III secolo a.C, come per esempio quella fornita dalla Katha Upanishad, oppure il modello a sei membra proposto dalla Maitry Upanishad. Ma il confronto non regge nemmeno con i testi hathayoga del XVIII secolo. Per capirci: lo yoga delle Upanishad antiche inizia direttamente col pranayama e ignora completamente gli asana. Ora, se noi da una lezione di yoga moderno togliamo le posture, che cosa rimane della pratica?
Se vogliamo misurare la distanza tra questi due Yoga, omonimi ma non omologhi, senza scomodare questioni teoriche basta considerare due aspetti della pratica che facciamo tutti i giorni. Il primo riguarda le numerose posizioni in piedi: prima del 1900 l’unico asana in stazione eretta era l’albero, vrikshasana. Ciò significa che ogni volta che pratichiamo una posizione stando in piedi, sia essa di equilibrio o di forza, si tratta di una introduzione recente. Stessa cosa vale per il saluto al sole, suryanamaskara: questa pratica non compare in nessuno dei trattati di hathayoga. In sintesi, quello che generalmente si sa e si fa dello yoga risale a non più di 150 anni. Anche la centralità di Patañjali è un fenomeno dovuto al revival dei promotori dello yoga moderno: pare non sia mai esistita una tradizione di yogin che facessero riferimento agli Yogasutra.
Oggi c’è un’ampia offerta di tanti tipi di yoga diversi. Come facciamo a scegliere quello giusto?
È semplice, è sufficiente un po’ di viveka, di discriminazione, e chiedersi: che cosa ha realizzato questo insegnante praticando per anni la sua disciplina? Dove è arrivato? Com’è la sua umanità? Mi interessa conseguire quel risultato?
Da cosa si riconosce un vero maestro yoga?
Lo yoga è un minuzioso processo di satvizzazione, pertanto il grado di realizzazione un insegnante si misura riconoscendo il suo guna prevalente, ossia osservando se la sua qualità umana è caratterizzata dal tamas (pesantezza), dal rajas (iperattivismo) o dal sattva (chiarezza e calma). Ho usato volutamente la parola ‘insegnante’, perché il ‘maestro’, secondo la tradizione, è triguna-rahita, oltre i tre guna.
Ma la risposta forse più radicale a questa domanda si trova nell’ultima strofe della Hatha-yoga-pradipika che recita:
“Finché il prana, percorrendo la via mediana, non penetra nel brahmarandra [cakra sommitale], finché il seme non diventa stabile per mezzo della ritenzione del respiro, finché la mente non diventa la medesima cosa con lo stato naturale (sahaja) per mezzo della meditazione, fino ad allora ciò che si dice sulla Conoscenza è solo una chiacchiera falsa e ipocrita” (IV.114).
C’è qualche praticante che possa dire di aver stabilmente conseguito uno di questi punti?
Lo yoga è più una forma di ginnastica o una pratica spirituale?
Lo yoga è stato concepito, e si è poi continuato a elaborarlo sino al XVIII secolo, come disciplina, sadhana, unitaria. Ma chi al giorno d’oggi si iscrive a un corso di yoga per ridurre le cinque cause delle proprie afflizioni esistenziali, ossia i klesha? A chi interessa il distacco o l’umiltà? Va poi aperta un’altra questione: nei corsi di formazione quali insegnanti sono qualificati per far sperimentare gli otto gradi del samadhi, o gli otto samapatti? Quale insegnante conosce sperimentalmente i quattro avastha (condizioni) del pranayama? Chi possiede l’abilità pratica (nella maggioranza dei casi è pura narrazione) di sciogliere i tre nodi energetici (granthi)?
Cos’è il modello dei quattro elementi?
Per la precisione si tratta di un modello a cinque elementi. Il quinto include i precedenti quattro, e l’unico a poterlo fare è l’elemento spazio, akasha tattva. Nella mia tradizione, l’Aghor Yoga, il modello si applica principalmente per invertire gli stati emotivi non desiderati. Nello specifico l’insegnamento consiste nel pormi delle domande che mi aiutano a riconoscere la situazione dal punto di vista non psicologico ma energetico: quando provo rabbia, o paura, o irrequietezza, oppure l’attitudine è di testardaggine, quale dei cinque elementi è dominante e quale è mancante? Dopo averli riconosciuti, dove posso trovare in natura, o con la visualizzazione, l’elemento deficitario per equilibrare il modello? Dietro a questa prassi vi è la concezione secondo cui tutto quello che esiste e si manifesta è come un tessuto intrecciato con i cinque elementi; si tratta di riconoscerli nel proprio animo così come nel proprio ambiente naturale, per poi assaporare la continuità tra quello che è esterno e quello che è interno, tra la logica della coscienza e la logica della natura, fino a intuire l’appartenenza a un unico campo di esistenza.
Chi è Edoardo Beato
Edoardo Beato, laureato in Filosofia comparata, ‘cultore della materia’ per le Discipline orientali all’Università di Padova, scholarship in Religious Studies presso la UCSB California, insegnante Yoga certificato negli Stati Uniti e in Italia, segue la tradizione Aghor Yoga di Aghoreshwar Baba Bhagwan Ramji. Tra i fondatori della rivista di filosofia comparativa Simplegadi, svolge attività di divulgazione delle filosofie dello Yoga unitamente alle loro prassi somatiche. Ha tradotto in italiano: Alan W. Watts, Om meditazioni creative, Neri Pozza; G. Feuerstein, Filosofia Yoga, Marsilio Editori.
Edoardo Beato sarà presente a Roma il 30 e 31 gennaio, con un incontro dal titolo “Il continuum tra pratica e filosofia nella tradizione dello yoga“.
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
You need to login or register to bookmark/favorite this content.


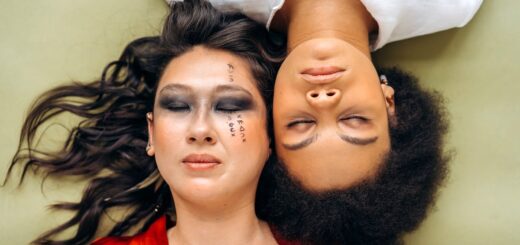




Grazie bellissimo articolo! Simona