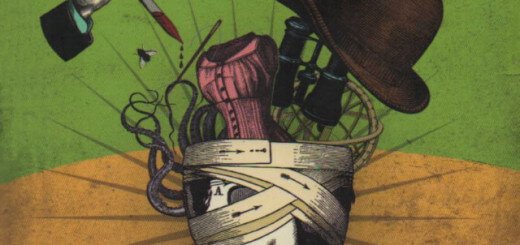Meditazione: significato di una parola ambigua

Qual è il significato di “meditazione“? L’uso di questo termine è molto ambiguo, nella nostra lingua, perché la parola “meditare” viene usata spesso quale sinonimo di “pensare” che invece non c’entra niente con la meditazione vera e propria. Vediamo allora qual è il significato di meditazione, specialmente alla luce di quanto hanno detto a proposito alcuni dei più importanti maestri in questo campo.
Indice dei contenuti
Significato di Meditazione come “non azione” o “non pensiero”
Significato di Meditazione come consapevolezza
Il significato di meditazione non è “pensare”
Significato di meditazione come scala che porta a Dio
Meditazione: significato molteplice per una stessa parola
Gom, familiarizzare con la mente
Significato di Meditazione come “non azione” o “non pensiero”
Il significato di meditazione può coincidere con la seguente definizione: uno spazio che intercorre tra un pensiero e il pensiero successivo. Krishnamurti ha detto che, osservando attentamente, si può notare come nel movimento del pensiero ci siano delle interruzioni, degli intervalli tra i pensieri. Tra due pensieri c’è un momento di silenzio che non dipende dal processo del pensiero stesso e che non appartiene al tempo. La mente per Krishnamurti è calma solo quando smette di conferire continuità al pensiero. È una calma non voluta, senza alcuna causa. Se questa è la meditazione, la sua caratteristica è proprio la “non azione” e il “non pensiero“. Si sta seduti e non si pensa a niente: ci si concentra magari sul respiro, si osserva quello che accade al corpo o alle sensazioni, ma non si pensa.
Meditazione significato come consapevolezza
Ajahn Chah, un grande maestro che è considerato l’iniziatore del moderno movimento della meditazione vipassana, ha dato una definizione molto interessante del significato di meditazione, che vi invito ad andare a leggere in questa pagina. Egli ha descritto così lo stato meditativo:
la mente è stabilmente focalizzata con omnicomprensiva consapevolezza, contenimento, e attenzione. Siete costantemente consapevoli del giusto e dello sbagliato, in costante osservazione di tutte le condizioni che sorgono nella mente. Quando vi capita improvvisamente di pensare a qualcosa, di sentire avversione o desiderio, ne siete consapevoli.
Il significato di meditazione non è “pensare”
Se dunque stiamo cercando il significato della parola meditazione, dobbiamo constatare come esso sia proprio il contrario di ciò che suggerisce la parola “meditazione”, usata in occidente e causa di molti equivoci. Essa deriva dal verbo latino mĕdĭtor – che indica l’attività di pensare, riflettere, considerare, in senso speculativo, in relazione ad un oggetto. E infatti si usava anche per indicare azioni più finalizzate, come preparare, procurare, macchinare, prepararsi, esercitarsi, studiare, comporre. Tale verbo fu adottato per tradurre in latino il termine greco melete, presente nella versione in greco della Bibbia. Melete significa ponderare, riflettere, contemplare, e fu usato a sua volta per tradurre l’ebraico hāgâ, che indica il sospiro, il mormorio, ma anche la meditazione stessa. Si badi però che, nel contesto ebraico, l’introspezione è sempre di tipo dualistico: da una parte il credente, dall’altra Dio.
Meditazione significato come scala che porta a Dio
Pare poi che l’uso della parola meditazione, per il significato che le attribuiamo oggi, sia arrivata a noi non per via buddhista, ma tramite un monaco certosino, Guigo II, priore del monastero della Grande Chartreuse, nelle Alpi francesi, nel XII secolo. Il suo primo libro, Scala Claustralium, o Lettera sulla vita contemplativa, è un classico della spiritualità cristiana e viene considerato quale prima descrizione della preghiera strutturata. Guigo paragona la vita spirituale ad una scala, proponendo una progressione in quattro gradini:
- la lettura attenta della Sacra Scrittura (lectio);
- la memorizzazione di quanto si è letto (meditatio);
- l’invocazione a Dio per ottenere ciò che la meditatio ha fatto conoscere (oratio);
- l’intimità con Dio nella preghiera (contemplatio).
Ecco di seguito cosa scrive Guigo, a proposito dei quattro gradi della vita spirituale.
Un giorno, mentre occupato in un lavoro manuale cominciai a pensare all’attività spirituale dell’uomo, tutt’a un tratto si presentarono alla mia riflessione quattro gradi spirituali: la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione: «lectio, meditatio, oratio, contemplatio».
Questa è la scala dei monaci, mediante la quale essi sono sollevati dalla terra al cielo, formata in realtà da pochi gradini, ma tuttavia d’immensa e incredibile altezza, di cui la parte inferiore è appoggiata a terra, mentre a superiore penetra le nubi e scruta i segreti dei cieli. Questi gradini, come sono diversi di nome e di numero, così so istinti per ordine e per importanza. Se qualcuno esaminerà con cura le proprietà e le funzioni che ciascuno di essi esercita su di noi, e come differiscano tra di loro e la loro gerarchia, stimerà breve e facile il lavoro e l’applicazione impiegati in questo studio, di fronte alla grande utilità e dolcezza che ne ritrarrà.
La lettura – lectio divina” – è lo studio assiduo delle Scritture, fatto con spirito attento. La meditazione è una diligente attività della mente, che cerca la conoscenza di verità nascoste, mediante l’aiuto della propria ragione. La preghiera è un fervoroso anelito del cuore verso Dio per allontanare il male e ottenere il bene. La contemplazione è una certa elevazione della mente al di sopra di sé verso Dio, gustando le gioie dell’eterna dolcezza.
È questa dunque la strada attraverso cui l’uso della parola meditazione è diventato parte della nostra eredità. Se non si conoscono tutti i passaggi sopra descritti, si finisce direttamente alla seguente equazione:
meditare = pensare
Da tale assunto deriva la comune opinione che si debba sempre meditare su qualcosa, ragionandoci sopra. La premessa per capire qual è il significato di meditazione è dunque affrancarsi da tale eredità. Non disconoscerla – perché siamo figli di quella stessa cultura di cui sia l’Antico Testamento, sia i greci, sia i certosini fanno parte – ma per lo meno contestualizzarla.
Meditazione: significato molteplice per una stessa parola
Ma la parola meditazione ha in realtà un significato più vasto, perché si ricollega a tante tradizioni diverse, anche solo guarando verso Oriente, che vanno dallo yoga al buddhismo alle Upanishad indiane. I diversi significati che si possono attribuire alla parola meditazione sono rappresentati da termini come gom, dhyāna, samādhi e zen, che rappresentano tante sfumature diverse e possono essere molto utili anche per chi non ha interessi intellettuali, ma vuole semplicemente approfondire la propria pratica personale.
Gom, familiarizzare con la mente
La meditazione comunemente intesa, quella di cui si parla in Zen in the City, ha sicuramente delle somiglianze con la Lectio Divina di Guigo II. Ma essa in realtà viene direttamente dall’Oriente. Se andiamo subito alla parola tibetana che indica la meditazione – Gom – troviamo una definizione molto pregnante, perché il suo significato è “familiarizzare con la propria mente”. Saperlo può aiutarci parecchio a comprendere più a fondo cos’è la meditazione.
Dhyāna e lo Yoga Sutra
Nelle grandi tradizioni spirituali, dalle quali abbiamo ereditato la pratica della meditazione – buddhismo e induismo – il termine equivalente è dhyāna. Dhyāna deriva dalla radice sanscrita dhyai, che ha un significato abbastanza ampio. Esso comprende il meditare in senso proprio (la consapevolezza), ma anche contemplare e pensare. Il termine compare per la prima volta nelle Upanishad, un insieme di testi religiosi e filosofici che costituisce la base del pensiero religioso indiano. In una di esse, in particolare, la Brihadaranyaka-Upanishad, la forma verbale nididhyasitavyah (si noti che questa lunga parola contiene la radice dhyai ) viene usata per indicare la meditazione sul Sé (atman).
Ma il testo più importante, cui fare riferimento, è lo Yoga Sutra, una collezione di aforismi sulla pratica dello yoga, attribuita al filosofo Patanjali, vissuto nel 2° secolo a.C.. È il testo che tutt’oggi costituisce la base teorica di tutto lo yoga. Secondo Patanjali, per arrivare a samādhi, lo stadio ultimo del percorso yogico, bisogna passare per altri sette stadi, o “membra” che lo precedono:
- i freni (yama);
- le discipline (niyama);
- le posizioni (āsana);
- il ritmo della respirazione (prāṇāyāma);
- l’emancipazione dell’attività sensoriale dall’influsso degli oggetti esterni (pra- tyāhāra);
- la concentrazione (dhāraṇā);
- la meditazione (dhyāna).
Dhyāna è uno stato particolare dell’attenzione, un flusso indisturbato di pensiero attorno all’oggetto della meditazione. Esso necessita di essere preceduto dagli altri stadi, e costituisce in realtà solo un passaggio. Quando, nel dhyāna, l’oggetto si rivela in sé stesso, non distorto da chi vi sta meditando, allora si ha il samādhi.
Il samādhi è lo stadio che si raggiunge quando ci si libera della meditazione, quando cioè non c’è più separazione tra l’oggetto meditato e il soggetto meditante. In un’accezione più ampia, tutte le ultime quattro membra del sistema di Patanjali – pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna e samādhi – costituiscono la pratica di meditazione. È la dimensione in cui si chiudono le porte dei sensi e l’attenzione del praticante si rivolge tutta verso l’interno. Le quattro membra che le precedono servono invece a preparare il corpo e la mente alla meditazione.
Ecco cosa dice il sutra III.3:
Supponi che io stia meditando su un libro, e che gradualmente sia riuscito a concentrare la mente su quello e percepire così soltanto sensazioni interne, il significato, inesprimibile in qualsiasi forma — questo stato del dhyāna è il samādhi.
Anche se i contesti e le epoche storiche sono lontanissimi, è interessante notare la similitudine tra l’approccio di Patanjali e quello di Guigo II. In entrambi i casi, la meditazione è uno degli stadi di una progressione verso l’Assoluto. Ciò implica, innanzi tutto, che siano necessari dei passaggi precedenti, ma anche che, grazie alla pratica di meditazione, sia possibile arrivare a qualcos’altro. Se volessimo paragonare tali schemi con l’approccio oggi prevalente, alla pratica ci consapevolezza, in occidente, potremmo ritrovare comunque una forma di progressione. La pratica della meditazione avrebbe un “prima” e un “dopo”:
- il prerequisito che la precede è il semplice sedersi con la giusta intenzione, per assumere una posizione che ci aiuti ad “acquietarci interiormente, e a entrare in contatto con un’intima sensazione di fiducia e dignità” (lo dice Pema Chödrön in “vivi nella bellezza“)
- il dopo è il risultato atteso, cioè l’illuminazione, o risveglio, o nirvana, ma forse – a conti fatti – qualcosa di leggermente meno ambizioso: scoprire la dimensione del “non sé” liberarsi dall’attaccamento e dall’avversione, liberarsi dall’idea di nascita e morte, vivere una vita felice.
Samādhi
Nel Buddhismo, dhyāna è la meditazione in riferimento ai vari stadi di samādhi. Nel contesto dei sutra attribuiti al Buddha – il termine samādhi ha un significato diverso, rispetto a quello visto nello Yoga Sutra. Qui indica uno stato di concentrazione, una condizione nella quale la mente è ferma e stabile ed è caratterizzata proprio da un’aumentata capacità di concentrazione.
Anche qui ci sono ci sono vari livelli, di profondità crescente: i quattro dhyāna. Si parte dal primo – nel quale si lasciano andare le passioni, i desideri e i pensieri– e si arriva all’ultimo, nel quale, abbandonate tutte le sensazioni, rimane solo una consapevolezza equanime.
A differenza che nello Yoga, e nel cammino spirituale dei certosini, la meditazione buddhista non si colloca all’interno di una progressione. È anzi collocata – a pari merito – nell’ambito di un insieme di 8 elementi, il nobile ottuplice sentiero, che costituiscono la via per liberarsi dalla sofferenza: retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione. La meditazione vera e propria corrisponde alla retta concentrazione (samādhi), ma anche alla retta presenza mentale (sati), uno stato che accompagna costantemente il praticante, grazie all’esercizio del samādhi.
La retta concentrazione può essere di tue tipi: attiva, quando la mente si concentra su qualsiasi cosa possa accadere al momento, o selettiva, quando la mente si concentra su un oggetto in particolare. Ciò può avvenire a vari livelli di profondità: i quattro dhyāna, per l’appunto. La concentrazione “ben sostenuta”, che caratterizza i praticanti assidui, può a sua volta dare origine all’insight, o comprensione risvegliata.
Sati è il termine pali (la lingua in cui sono scritti i testi buddhisti) equivalente alla parola inglese mindfulness (presenza mentale, consapevolezza, attenzione consapevole). La parola sanscrita corrispondente è invece smrti, che significa “ricordare”, cioè ricordare di tornare al momento presente. I possibili oggetti della presenza mentale sono quattro, secondo i testi buddhisti: il corpo, le sensazioni, la mente e gli oggetti mentali. Per il buddhismo, infatti, il centro d’interesse è sempre l’osservazione di se stessi. La presenza mentale è in un rapporto di interdipendenza, con gli altri sette elementi del nobile sentiero, non di progressione. Ad esempio, la presenza mentale rende più facile la retta parola ed è al contempo facilitata dal retto sforzo.
Meditazione significato nello Zen
Lo Zen ha accentuato la dimensione della presenza mentale, cioè di uno stato di attenzione costante, col fine di vivere nel momento presente in qualunque circostanza. E pure di goderselo, il momento presente, secondo l’approccio alla Thich Nhat Hanh. Nei discorsi di questo maestro, una delle parole più ricorrenti è enjoy, cioè godere. Anche la dimensione della concentrazione è vista come un’attitudine che conforma l’intera vita del praticante. È ad esempio il caso della persona che, adottando una postura e dei movimenti consapevoli, rende più bello il proprio corpo.
La stessa parola giapponese Zen ha da insegnarci qualcosa. Viene dal cinese chán, che a sua volta è l’equivalente di dhyāna. Perciò:
zen = meditazione = concentrazione + presenza mentale
L’etimologia ci aiuta a capire meglio l’essenza dello zen, il cui approccio è fortemente incentrato sulla pratica. La presenza mentale – resa possibile da una regolare attività di meditazione, intesa come samādhi – è già dunque sufficiente a spiegare lo Zen.
[Il brano citato è tratto da: Epistola de vita contemplativa, in: Un itinerario di contemplazione – Antologia di autori certosini, Edizioni S. Paolo, 1987, Terza edizione 1996, riportato in questa pagina]
Per conoscere la storia completa del significato di “meditazione”, scarica l’articolo completo (solo utenti registrati):
Scarica il PDF:
Meditazione: significato di una parola ambigua[/ihc-hide-content]
Vuoi ricevere gli aggiornamenti da Zen in the City?
Inserisci il tuo indirizzo per ricevere aggiornamenti (non più di 1 a settimana):
Zen in the city. L’arte di fermarsi in un mondo che corre
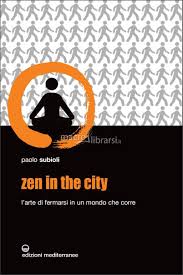
You need to login or register to bookmark/favorite this content.