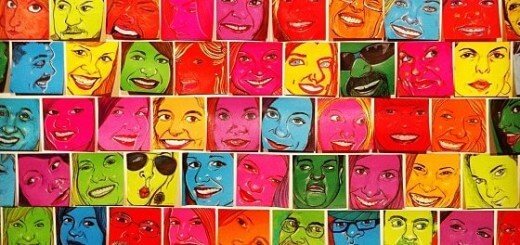Non cercare su Google: ecco un’idea per diventare più aperti e intelligenti

Non cercare su Google: sembra un’idea stupida, perché il motore di ricerca più usato al mondo permette di trovare veramente di tutto nel giro di secondi, oltre che di fugare all’istante qualsiasi dubbio. Ma questa meraviglia tecnologica ha anche un sacco di controindicazioni, specie nei confronti della nostra capacità reale di comprendere a fondo la realtà. Ora vi spiegherò perché, premettendo subito che non propongo affatto di tornare ai metodi pre-internet, ma di adottare delle alternative, tra le quali il motore DuckDuckGo.
Perché non cercare su Google
Per gli amanti della privacy, il motivo principale per non cercare su Google è che la società americana traccia ogni nostro comportamento online, col fine di profilarci e creare la pubblicità più attraente per noi. Google possiede l’omonimo motore, ma anche YouTube, Chrome, la Gmail, Google Maps, Android, Google Analytics (lo strumento usato dai siti per misurare le visite) e gli spazi pubblicitari su decine di milioni di siti web (tra cui questo, in tutta onestà). Dunque è in grado di intercettarci e spiarci praticamente qualsiasi cosa facciamo online, creando di noi un profilo molto accurato.
Per qualcuno la privacy non è un problema. Io sono più o meno tra questi, avendo scritto più volte che la quantità di tracce di noi che lasciamo online ci consente dopotutto di vedere il nostro karma digitale e così di conoscere meglio noi stessi e ciò che di noi stessi diamo al mondo. Inoltre non bisogna dimenticare che il tracciamento è il prezzo da pagare per avere gratis tutti i servizi come quelli di Google. Però non è neanche bello che le aziende digitali facciano soldi spiandoci a nostra insaputa e in modo poco trasparente. Inoltre un confine bisogna pur metterlo. Anche quelli tra noi più aperti e trasparenti, quando vanno in bagno, la porta la chiudono.
Primo problema: la Filter Bubble
Il primo grande problema per me è la cosiddetta Filter Bubble, o bolla di filtraggio o bolla informativa. Con Filter Bubble si intende l’insieme degli effetti che derivano dalla personalizzazione dei risultati di ricerca su siti come Google e Facebook, che registrano la storia del nostro comportamento. Utilizzando informazioni su di noi (posizione, click precedenti, ricerche passate), Google sceglie selettivamente tra tutte le risposte quelle che noi vorremo vedere. L’effetto è di tenerci lontani da informazioni che sono in contrasto con il nostro punto di vista, isolandoci nella nostra “bolla” culturale o ideologica.
La Filter Bubble è un problema serio, perché tende a racchiudere le persone in recinti autoreferenziali, all’interno dei quali tutti la pensano più o meno allo stesso modo. Il risultato è che ci si chiude allo scambio di opinioni, alla possibilità anche solo parziale di cambiare idea. Ne consegue che le posizioni si radicalizzano sempre di più e vengono favoriti gli estremismi a danno del dialogo. Le bolle informative sono talmente chiuse che al loro interno, in certi casi, nemmeno la scienza riesce a penetrare. Lo si è visto con i movimenti no vax, ma riescono a prosperare persino movimenti che sostengono che la terra è piatta, i cui membri si fomentano a vicenda rifiutando qualsiasi fonte informativa ufficiale. Anche il jihadismo si alimenta degli stessi meccanismi, convincendo ragazzi che non sono mai entrati in una moschea che tutti gli infedeli vanno eliminati.
Siamo arrivati a un paradosso nel quale internet, la rete che contiene tutte le informazioni del mondo e che consente uno scambio di informazioni e di idee senza precedenti nella storia dell’umanità, alimenta la chiusura mentale e la superstizione. Ma la mindfulness serve proprio a evitare gli automatismi e scegliere, prima di compiere anche le azioni apparentemente più neutre.
Un’alternativa: DuckDuckGo
Nel mio libro “Ama il tuo smartphone come te stesso” ho proposto come esercizio la “Ricerca su Google con apertura mentale” (p. 97), suggerendo anche che il cervello, per rimanere in salute, ha costantemente bisogno di conoscere qualcosa di nuovo. Il metodo proposto era di cercare su google.com, anzché google.it, e di utilizzare la navigazione anonima del browser, per guardare al di fuori della propria “filter bubble”.
Ma c’è un metodo che mi sembra più semplice ed efficace; utilizzare direttamente un altro motore, DuckDuckGo, che cerca senza tracciare l’utente e senza tenere conto della posizione. Il fatto che io ora mi trovi a Roma, ad esempio, non fa di me una persona interessata solo a ciò che accade in Italia e nella mia città. DuckDuckGo funzione bene come motore di ricerca e promette di dare a tutti gli stessi risultati. È disponibile anche come estensione di Firefox, il browser libero e open source che, non essendo di nessuno, non traccia le attività dei suoi utenti, a differenza di Chrome e di Safari.
Secondo problema: l’illusione della conoscenza facile
Un altro grosso problema è che Google sta cambiando il nostro modo di pensare. Ci sono ricerche scientifiche, messe in luce dalla bravissima Maggie Jackson, che evidenziano la correlazione tra la possibilità di trovare immediatamente informazioni e l’incapacità di affrontare problemi complessi. Google, con la sua disponibilità e facilità d’uso, ci ha abituato male. Subito dopo una ricerca – secondo questi studi condotti sia a Yale che a Harvard – crolla il nostro “bisogno di cognizione”, cioè la disponibilità a confrontarsi con un problema e ad approfondirlo.
La ricerca online porta a un atteggiamento di presunzione, a ritenere di saperne di più di quanto in realtà non sappiamo. Tendiamo così a sopravvalutare la nostra capacità di rispondere a domande simili quando siamo offline. A forza di “googlare”, ci illudiamo che conoscere sia facile. Quando siamo online non siamo mai messi di fronte alla nostra ignoranza, dice Maggie Jackson. Così ci sembra che conoscere sia qualcosa di veloce, facilmente accessibile, facile. Ma senza l’assunzione di “non sapere” è difficile affrontare problemi complessi. Su Facebook si assiste così a un fenomeno analogo: abituate alla risposta facile e immediata, molte persone si accontentano di vedere i titoli delle notizie, senza neanche leggere l’articolo, facendo così la fortuna dei diffusori di fake news pubblicate ad arte. Ne sono un esempio perfetto le finte foto circolate in questi giorni dei terremotati di Amatrice sotto la neve, che in realtà erano di un campo profughi in Libano.
Nella realtà- cioè al di fuori del giardino rassicurante di Google o Facebook – affrontare le questioni complesse significa dover lottare, e andare molto oltre la prima risposta che ci viene in mente. Essere disposti a cercare ulteriormente, a confrontarsi con l’ignoto. L’incertezza non è necessariamente negativa, dice giustamente Jackson. Implica la presenza di una possibilità. Possiamo fermarci e cominciare a pensare in modo flessibile, immaginativo, ostinato. Stiamo diventando un po’ tutti prede di una “impazienza cognitiva” che ci rende sempre meno capaci di conoscere e interpretare il mondo.
Per contenere questo fenomeno, non ci sono soluzioni tecnologiche come DuckDuckGo, ma solo la nostra consapevolezza. Dobbiamo imparare a moderare la nostra presunzione cognitiva e, almeno ogni tanto, resistere alla tentazione di cercare il telefonino per poter googlare. Non mi ricordo il nome dell’attore di quel film? Pazienza. Quanti abitanti ha New York? Alla prima occasione utile cercherò di saperlo. Meglio sapere due cose in meno che educare il nostro cervello a una presunzione distruttiva.
Per approfondire:
Ama il tuo smartphone come te stesso. Essere più felici al tempo dei social grazie alla digital mindfulness
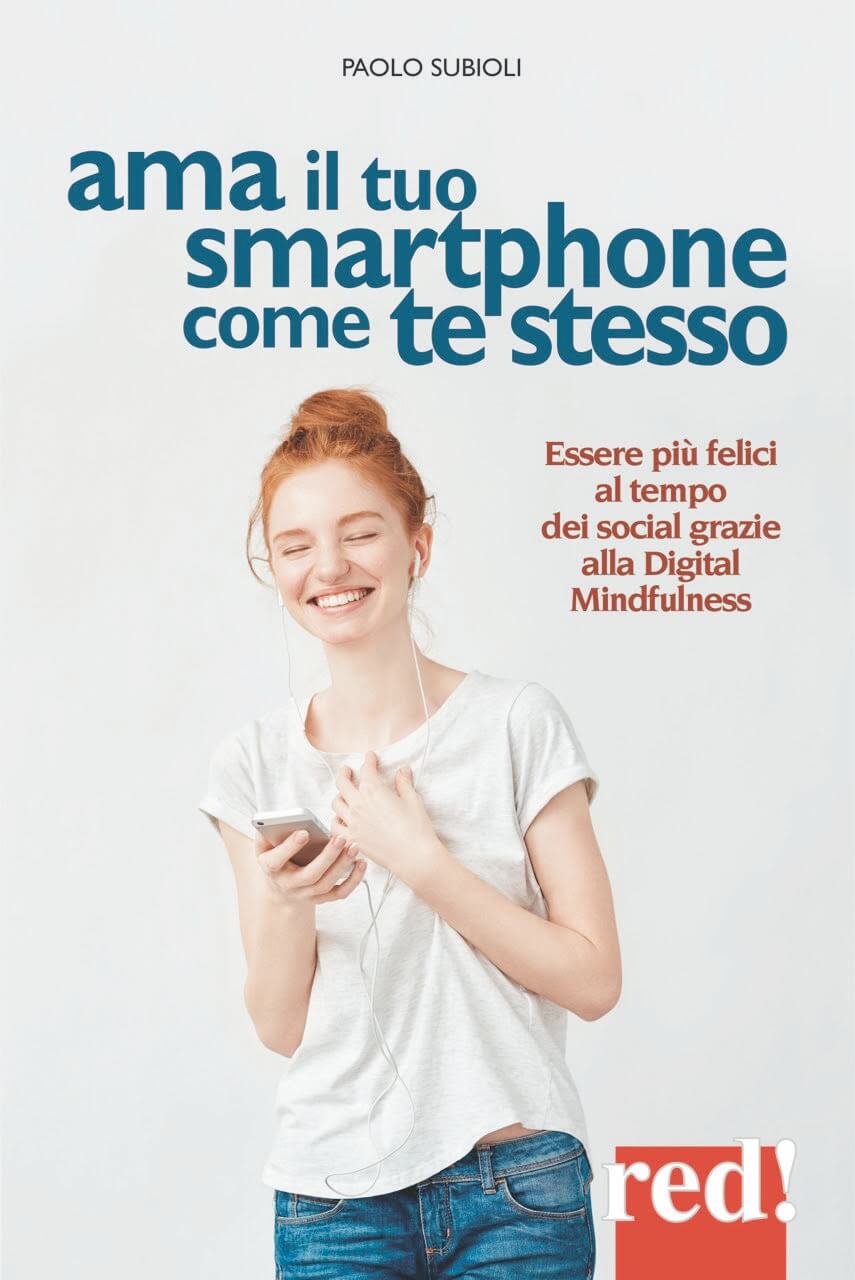
You need to login or register to bookmark/favorite this content.